Il fuggiasco
M i sono sposato nella primavera del 2004, e nel mese di luglio mi sono ammalato di varicella. Mi rendo conto che la scienza della medicina si sdegnerebbe anche solo all’idea di azzardare un’ipotesi di correlazione tra i due avvenimenti, né è mia intenzione alludervi. Fatto sta che mia madre, che ha esercitato la professione di pediatra per quattro decenni, si era zelantemente adoperata nei miei precedenti 26 anni di vita per mettermi a contatto con lo zoster. E non per una delle tante degenerazioni sadiche delle madri nei confronti dei propri figli, ma semplicemente per evitarmi il contagio da adulto, quando è risaputo che l’infezione è assai più debilitante per l’organismo. Ma era risultato evidente che il mio sistema immunitario, alla sola visione di quel virus, riusciva ad imporgli ogni volta ostacoli insormontabili, tipo per le mie figlie riuscire a percorrere senza sporcare il vestito nuovo i sei metri del vialetto d’ingresso che separano l’uscio di casa dalla portiera posteriore dell’automobile. Così immagino che in quella estate 2004, dopo un primo momento di sbigottimento nel trovare il nemico di sempre in stato catatonico, lo zoster abbia deciso di farmi pagare tutte le umiliazioni che aveva dovuto subire in precedenza: fu una vera e propria invasione, che mi rese mostruosamente debole per due settimane, esteticamente poco piacevole, e per qualche giorno rimbecillito oltre il lecito per via della febbre attestata stabilmente sopra i 40°.
Ogni evento porta con sé rischi ed opportunità, quello che conta è sapere evitare i primi e cogliere le seconde. A quel tempo non avevo ancora particolari responsabilità sul lavoro, non avevo figli, e nemmeno cani; pertanto potei candidamente abbandonarmi alla compagnia della televisione ed alla visione di tre o quattro film al giorno. E’ stato così che una mattina verso le 11 mi sono imbattuto ne “il fuggiasco”, rimanendone istantaneamente catturato. L’intreccio narrativo sembrava davvero costruito su un fatto realmente accaduto (e infatti ne ebbi conferma a fine pellicola), e la forza d’animo e coerenza del protagonista mi scatenarono un immediato moto interiore di solidarietà con lui. Talmente tanta fu la solidarietà, che registrai quanto mi mancava al termine del film per poterlo terminare con calma nel pomeriggio: era infatti giunta l’ora di pranzo, un momento per me sempre sacro e di dovuta tensione goduriosa (quasi sempre, anche quando sono indisposto). Non ricordo quanto accento vi fosse nel film relativamente alla bulimia di Massimo Carlotto. Ma sono quasi certo che non possa assurgere ai celestiali livelli descrittivi raggiunti nel suo libro: roba da sentire i profumi e far salire l’appetito in ogni istante della giornata (sensazioni che comunque mi sono decisamente famigliari). Non me ne voglia il buon Carlotto se, a differenza sua, almeno per il momento faccio parte di quell’universo di prediletti che mangia come un branco di bufali senza ingrassare di un etto (ma siccome viaggio verso i 40, confido che il metabolismo ormai non mi faccia scherzi). E sarà forse anche per questo che ho colto in questo passaggio del suo romanzo, ovvero della sua vita, soprattutto l’aspetto più “gastronomico” della cosa, e molto meno invece quello drammatico delle conseguenze sulla sua salute; dell’insorgenza della patologia come conseguenza di una esperienza di prigionia; e della sua evidente manifestazione di natura psicotica generata dalla solitudine e dall’esperienza alienante della latitanza. Parallelamente alla mia soggettiva percezione, viaggia però oggettivamente l’encomiabile capacità dello scrittore di cucinare ogni avvenimento del suo tragico destino in salsa agrodolce, facendo uso di un ingrediente unico per la caratteristica di riuscire piacevole solo se dosato in misura perfettamente equilibrata: l’autoironia.
Il viaggio che la mente del lettore è invitato a compiere attraverso le pagine del libro è di natura drammatica, poiché ripercorre le tappe dell’odissea giudiziaria ed esistenziale dell’autore. Un viaggio attraverso un manifesto della malagiustizia italiana, divenuto il “caso Carlotto”, capace nel corso di quasi due decenni di emettere a più riprese e diversi gradi di giudizio verdetti altalenanti di innocenza e colpevolezza. Ma è soprattutto il viaggio attraverso gli stati d’animo del malcapitato protagonista, e del variegato universo umano e anche geografico, da Parigi a Città del Messico, con il quale ha condiviso paturnie, esili, dibattiti politici ed azioni di lotta sociale. E’ impossibile non riflettere sul fatto che lo sfondo politico e sociale della vicenda stia all’origine della sua genesi. Eppure, allo stesso tempo, esso è anche stato alla base della sopravvivenza del latitante. Perché se è verosimile che se Massimo Carlotto non fosse stato un appartenente a Lotta Continua, probabilmente avrebbe avuto maggiori possibilità di non essere investito dell’onere sacrificale di capro espiatorio, lo è altrettanto che proprio il sostegno, l’amicizia, la condivisione della sua condizione da parte dei latitanti dei tanti movimenti intellettuali di natura comunista frequentati nei suoi spostamenti, siano stati fondamentali per aiutarlo a rimanere vivo e, all’interno della prigionia dell’esilio forzato, libero.
Al di là di una piacevolissima scorrevolezza in quanto a stile e costruzione narrativa del testo, vorrei sottolineare le due cose che ho particolarmente apprezzato. La prima in fondo l’ho già accennata, rimarcando la capacità di autoironia dell’autore (immagino sia stato obbligato a sviluppare questa qualità, che magari già possedeva prima dei suoi 19 anni, per poter sopravvivere). Sono consapevole del fatto che sofferenza e disperazione non siano misurabili poiché emozioni di tipo individuale. Ritengo comunque lecito spezzare una lancia in favore della capacità di Carlotto di aver saputo creare una atmosfera leggera nella quale si dipana una trama angosciante, profonda, e che, con il sorriso, induce a riflessioni su più fronti. La seconda, invece, attiene al merito di essere riuscito a tracciare un quadro politico di riferimento, senza sottrarsi né a simpatizzare né a lasciar trasparire un certo spirito critico. Ritengo possibile, almeno in teoria, che alcuni compagni possano storcere il naso in alcuni passaggi. Ed altrettanto, io che sono cresciuto da due genitori liberali orfani politici di Malagodi, che qualcuno sia portato ad eludere la lettura del testo, anche quando consigliata, perché impossibilitati a non ritenere un ossimoro l’accostamento della figura di “innocente” a quella di “militante di Lotta Continua”. Per mia fortuna la mia educazione in tema politico è stata davvero improntata sulla totale libertà. Forse troppa, al punto che talmente scevro da condizionamenti non riesco a collocarmi in nessun “distretto” elettorale, convivendo in me una certa cultura dell’impegno individuale di tipica impronta liberale, e un radicato senso etico di giustizia sociale marcatamente vicina ai movimenti progressisti. Se dovessi dare retta ai risultati dei test online di sondaggio politico, di quelli che proliferano come funghi in prossimità di qualche tornata elettorale (so bene che l’esito del questionario ha la stessa attendibilità dei calciatori quando si muovono verso l’arbitro facendo cenno di aver preso il pallone, anche quando hanno appena vivisezionato il crociato anteriore del ginocchio dell’avversario), ogni volta dovrei chiamare il medico e confessare il mio stato di sdoppiamento della personalità. Sarà anche per questo che, per tornare alle metafore gastronomiche, ogni aneddoto riportato da Carlotto sugli ambienti intellettuali frequentati mi ha stuzzicato l’appetito. Del resto, io sono nato nella seconda metà degli anni 70. Quando avevo 19 anni ogni dibattito politico era già morto e sepolto, sostituito, non solo nelle mafie locali ma anche nel mondo mediatico, da personalismi e convenienze. Ed anche se io a quell’età appartenevo probabilmente al decile di ventenni che inseguiva comunque una propria identità in merito, leggendo e studiando libri, manuali e mesti bigini, è innegabile che la mia generazione non trascorreva le ore dividendosi tra trotskyisti e leninisti, ma valutando se il black album dei Metallica (che in realtà non si chiama black album, lo so!) segnasse già l’inizio della fine della loro storia nel mondo del Metal, oppure no (la risposta per quanto mi riguardava era “sì”, e vent’anni dopo non ho comunque cambiato idea … ).
Il fuggiasco è una storia di prigionia e latitanza. Eppure ti porta a respirare e a sentirti libero.
Mason Merton



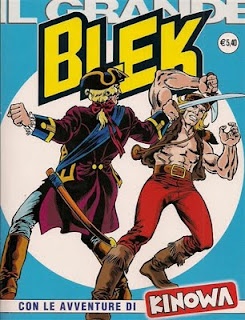
.jpg)

Commenti
Posta un commento
i vostri commenti sono molto apprezzati